L'area dell'attuale centro di Firenze è già frequentata
/ 750 a.C.
/ 750 a.C.
Attorno alla prima metà dell’VIII sec. a.C., poco prima cioè della fondazione di Roma, i resti di alcuni individui vengono seppelliti all’interno di vasi cinerari in una piccola necropoli posta al bordo dell’attuale piazza della Repubblica. Le tombe, fornite di semplici corredi funerari, rappresentano una prima testimonianza della permanenza umana in quest’area, forse già legata a qualche insediamento stabile e a un percorso di attraversamento dell’Arno.
explore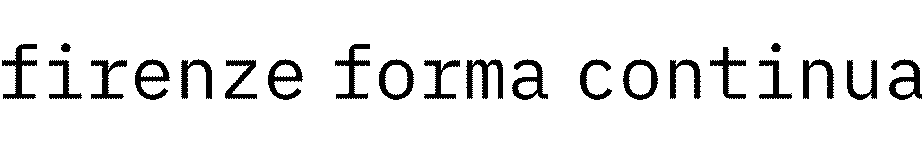

 fiumi
fiumi mura
mura strade
strade architetture emergenti
architetture emergenti porte di accesso
porte di accesso insediamenti dentro le mura
insediamenti dentro le mura insediamenti fuori le mura
insediamenti fuori le mura parchi
parchi
