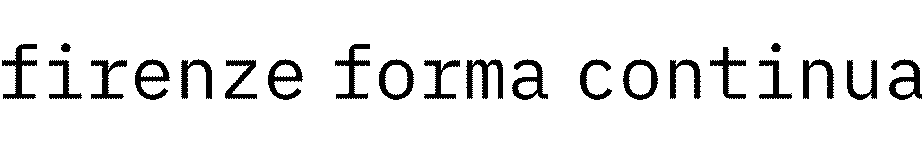Dopo la conquista dell’Italia centro-settentrionale da parte dei Franchi e del loro re Carlo Magno, nel 774, il territorio del precedente ducato longobardo di Tuscia viene riorganizzato, affidandolo a un margravio – o marchese – e suddividendolo in comitati, capeggiati da conti. Firenze diventa sede di uno dei comitati più importanti della regione, al quale nell’854 viene annesso anche quello di Fiesole.
Le rare fonti documentarie a disposizione e la scarsità di dati archeologici rendono molto difficile ricostruire l’assetto urbano della Firenze altomedievale, così come le sue strutture economiche, sociali e di potere. Emerge tuttavia il perdurare di una situazione di decadenza, che si riflette nell’impianto urbano, nella diffusione e nella dimensione degli edifici pubblici e privati, nelle tecniche costruttive utilizzate. Il tessuto urbano, ormai molto rarefatto, è adesso costituito per lo più da un’edilizia elementare fatta di piccole case a uno o due piani, in terra cruda e legno, con ampi spazi vuoti occupati da orti e pertinenze. Gli edifici antichi ancora esistenti vengono riassorbiti da queste semplici costruzioni, o sono riutilizzati per altri scopi.
Le fonti non fanno menzione delle mura fino al X sec., ma è molto probabile che quelle di epoca romana, riadattate in età tardoantica, cingano la città durante tutto l’Alto Medioevo, e vengano riparate e rimesse in efficienza tra il IX e il X secolo, quando Firenze è oggetto di incursioni ungare e scandinave. La leggenda di una loro ricostruzione da parte di Carlo Magno è priva di fondamento, ma è la spia di un fenomeno di riorganizzazione urbana che comincia a manifestarsi adesso.
La presenza di un ceto aristocratico che ambisce a ruoli di potere e la nuova importanza del vescovo, detentore di un patrimonio crescente di terreni e di beni in città e nel territorio circostante, hanno un effetto anche sulla struttura urbana e sulla sua organizzazione.
Il vescovato utilizza i propri beni come strumento per assicurarsi l’appoggio di famiglie aristocratiche, concedendo loro proprietà terriere; l’aristocrazia rinsalda il suo legame con la Chiesa costruendo e dotando monasteri e chiese. Questo fenomeno, già iniziato in epoca longobarda, produce una serie di edifici religiosi – oratori, piccole chiese, semplici edifici monastici – sia all’interno che all’esterno della città.
A differenza delle grandi basiliche tardoantiche, questi edifici hanno in genere dimensioni contenute e sono costruiti con materiali e tecniche più poveri. La loro esistenza è documentata da qualche fonte e da pochissime testimonianze archeologiche, tra cui i resti di alcune chiese altomedievali rintracciabili nelle strutture sotterranee di edifici posteriori, come a S. Trinita e a S. Pier Scheraggio. Tra il IX e il X sec. questa rete di piccole chiese sembra già dare vita al sistema delle parrocchie, che organizza la vita religiosa della città seguendone e indirizzandone al contempo le dinamiche insediative. Un ruolo simile hanno i monasteri urbani.
Il vescovo sceglie invece la basilica di S. Salvatore-S. Reparata come propria sede definitiva. In epoca carolingia la basilica è la più grande chiesa all’interno della città e forse ancora in buone condizioni. Alla fine del IX secolo viene parzialmente ristrutturata e vi sono traslate le spoglie di S. Zanobi, fino a questo momento conservate a S. Lorenzo. È possibile che la traslazione accompagni lo spostamento o la riconferma della cattedra vescovile in S. Reparata, nei pressi della quale esiste anche un battistero dedicato a S. Giovanni – probabilmente diverso da quello attuale – un palazzo vescovile, attestato fin dall’897 ma forse già esistente, e una canonica. Questo polo costituisce fin da adesso il principale centro religioso della città, mantenendo questo ruolo fino a oggi.
BIBLIOGRAFIA
- G. Vannini, Florentia altomedievale: le mura carolinge, storia e topografia di un mito di fondazione, in Metodologia, insediamenti urbani e produzioni. Il contributo di Gabriella Maetzke e le attuali prospettive delle ricerche, Convegno Internazionale di Studi sull’archeologia medievale in memoria di Gabriella Maetzke (Viterbo, 25-27 novembre 2004), Viterbo, Sette Città, 2008, pp. 437-478.
- E. Scampoli, Firenze, archeologia di una città (secoli I a.C. – XIII d.C.), Firenze, Firenze University Press, 2010.
- Archeologia invisibile a Firenze. Storia degli scavi e delle scoperte tra San Lorenzo, Santa Maria Novella e Fortezza da Basso, a cura di M. Salvini e S. Faralli, Firenze, Edizioni dell’Assemblea, 2020.